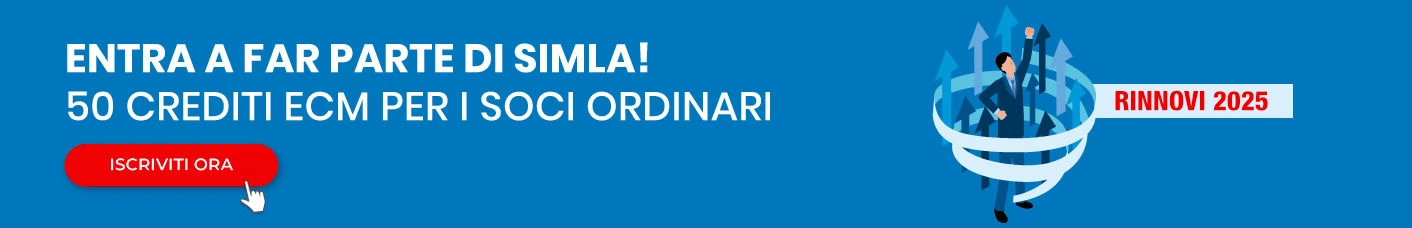In questo articolo si vuole partire dal considerare la recente introduzione del nuovo sistema di valutazione della disabilità in ambito previdenziale, che, nel tempo, dovrebbe andare a sostituire il vecchio sistema dell’invalidità civile e dell’handicap.
La rivoluzione nel passaggio dall’invalidità civile alla nuova legge sulla disabilità
Senza volersi soffermare troppo ad approfondire un argomento che è già stato ampiamente affrontato in due interessanti articoli pubblicati sulla Rivista Italiana di Medicina Legale[1] [2] (ai quali si rimanda consigliandone una lettura approfondita), ci si limita a richiamare il concetto di fondo da cui si dovrebbe partire per affrontare il tema dell’assistenza a soggetti prima ritenuti “invalidi” e, da qui in avanti, “disabili”: garantire un miglior inquadramento delle necessità di un soggetto attraverso l’analisi delle sue oggettive limitazioni nelle attività confacenti all’età e nella partecipazione attiva nella Società.
Il disposto, va detto, ha una finalità, prima di tutto, previdenziale, ma merita di essere analizzato anche da un punto di vista più “assicurativo”, perché offre uno spunto riflessivo importante.
Di fatto, si supera il concetto di capacità lavorativa, ancorato alla vecchia concezione del valore del soggetto all’interno della Società, fondato sulla sua capacità di produrre reddito.
Esiste, a mio avviso, una portata innovativa per l’evoluzione della nostra Società moderna, ma prima occorre fare alcune premesse.
Dalla incapacità lavorativa alla disabilità in un paese che invecchia
La previsione è che nei prossimi decenni il volume di potenziali utenti aumenterà in senso esponenziale.
Per dare un’idea sulla portata del fenomeno, il rapporto OASI 2022[3] attesta che l’Italia rappresenta il Paese dell’Unione Europea con il numero maggiore di anziani ultra 65enni (21% della popolazione) – oltre 14 milioni, di cui 3.8 milioni considerati non autosufficienti – numero che pare destinato a raddoppiare entro il 2030. Di questi, attualmente, circa 1.4 milioni di anziani sono titolari di indennità di accompagnamento (con una spesa pubblica di circa 8,8 miliardi di euro) e altri 2.7 milioni versano in condizioni tali da comprometterne a vario grado l’autonomia (e potrebbero, presto o tardi, accedere ai benefici previdenziali previsti per la non autosufficienza).
I numeri, come anticipato, sono impressionanti, ma ancora più impressionante è l’impatto economico che potrebbero avere sulle generazioni future. L’aumento della spesa pubblica è legato, in prevalenza, all’allungamento dell’aspettativa di vita e all’aumento delle patologie croniche invalidanti; quindi, più si andrà avanti, più aumenteranno i soggetti aventi diritto ad accedere al beneficio previdenziale.
Nuove sfide anche per il settore assicurativo
In un simile contesto, sorgono numerosi dubbi sul fatto che, in una Società come la nostra, che si trova, spesso, ad affrontare nuove sfide trascinandosi dietro il fardello di storiche decisioni politiche e sociali prese senza alcuna riflessione a lungo termine, il sistema riesca ad “assorbire” dal punto di vista economico questa nuova sfida, che, per quanto possieda tutto un senso sociale, morale e costituzionale, rischia di impattare economicamente in modo inimmaginabile (e ci si chiede se di questo si sia tenuto conto nel recepire la normativa internazionale dell’OMS, affidando la sostenibilità del impianto normativo alle coperture del PNRR!).
E allora, veniamo al punto cruciale di questo intervento: può il sistema assicurativo privato essere coinvolto in questo “progetto sociale”?
La risposta non può essere data dal sottoscritto, almeno non in forma assoluta, perché mancano diverse competenze specifiche.
Tuttavia, mi permetto di proporre alcuni spunti di riflessione.
Come noto, tra i prodotti assicurativi privati sempre meno diffusi, perché giudicati poco utili, vi è la polizza malattia.
La polizza invalidità permanente da malattia
Il concetto di polizza malattia nasce diversi decenni fa insieme alla polizza infortuni, traendo spunto proprio dal modello previdenziale, con l’obbiettivo primario di assicurare il rischio di ridurre o non poter più provvedere economicamente ai propri bisogni[4].
Quali sono i limiti principali della polizza malattia?
Nell’epoca moderna, il fatto che, spesso, il concretizzarsi di una condizione patologica potenzialmente assicurabile, non coincide con un adeguato riconoscimento economico in termini di indennizzo.
Grazie anche al costante miglioramento delle cure, un soggetto che sviluppa una malattia, frequentemente, va incontro ad una temporanea e prolungata impossibilità a produrre un reddito sufficiente, senza tuttavia poter tutelare tale condizione in modo efficace, poiché affetto da un processo fisiopatologico ancora in evoluzione; salvo poi raggiungere una condizione potenzialmente assicurabile solo in una fase terminale, quando ormai, nella migliore delle ipotesi, si è stabilizzato con un recupero della sua capacità entro valori sotto franchigia, o, nella peggiore delle ipotesi, con valori sopra franchigia, ma con una prognosi quoad vitam sfavorevole nel breve termine (in questo senso, si pensi alle neoplasie).
È chiaro che un prodotto assicurativo ancorato alla capacità lavorativa (peraltro ultra-generica) non farà altro che risultare sempre meno utile e, quindi, poco appetibile per il mercato. È un effetto distorsivo, una conseguenza negativa di un’altra, invece, positiva, legata al miglioramento delle cure e all’evoluzione della Società.
Le polizze LTC (Long Term Care)
Ed è qui che si richiama l’attenzione su nuove frontiere assicurative, in particolare sulla polizza LTC.
Il prodotto appartiene al ramo “vita” (a tutela del danno emergente), che è differente dal ramo “danni” della polizza malattia (a tutela del lucro cessante), soprattutto come gestione, ma che si fonda su un concetto sicuramente più aggiornato – quello della non autosufficienza – in linea con le nuove disposizioni della legge sulla disabilità.
Certo, la metodologia valutativa segue presupposti (e logiche assicurative) differenti, ma è sicuramente un modello privato che potrebbe trovare ampio spazio per integrarsi con quello previdenziale.
Sul piano economico, il diffondersi di piani assicurativi LTC potrebbe garantire la sostenibilità di un sistema altrimenti destinato a vedere ridotta sempre più la sua efficienza (un po’ come da diverso tempo accade, in ambito pensionistico, con le polizze integrative), principalmente per il limitato impatto economico del beneficio previdenziale, non certo destinato ad aumentare nel prossimo futuro, semmai a ridursi a fronte del sicuro aumento dei soggetti aventi diritto.
Una nuova clientela “anziana”
La nostra Società è destinata ad invecchiare sempre di più e ad avere sempre meno giovani in grado di fornire assistenza e ausilio agli anziani. Questi ultimi sono destinati a ritrovarsi sempre più frequentemente in condizioni di non autosufficienza (per invecchiamento fisiologico o per sviluppo di patologie invalidanti, ma non mortali), ma con disponibilità economiche sempre più contenute (viste le pensioni sempre più basse).
È palese che oggi ci troviamo ad affrontare il problema di persone anziane che nella loro storia lavorativa non hanno mai versato contributi previdenziali sufficienti a garantire una pensione adeguata. Ed è altrettanto palese che sempre meno giovani trovano un valido impiego adeguatamente remunerato, anche dal punto di vista contributivo o che, comunque, si impegnano in tal senso per poterselo garantire.
Il destino è quello di trovarsi una platea sempre più numerosa di soggetti non autosufficienti, senza alcun supporto di gratuito da parte di terzi e con una disponibilità economica del tutto limitata.
In quest’ottica, la potenziale platea per un prodotto assicurativo privato che possa integrare il beneficio previdenziale previsto in caso di non autosufficienza è sicuramente allettante, sia in termini di ricaduta economica per il mercato assicurativo, sia per la sua potenziale utilità sociale.
Personalmente, ritengo che si dovrebbe partire da un confronto culturale sul tema, prima di tutto nel mondo medico-legale, che, in un simile contesto, potrebbe sicuramente offrire un valido supporto tecnico, sia alle compagnie assicurative che ai cittadini.
Fonti bibliografiche
[1] Martelloni et al. La legge 227 del 22 dicembre 2021 e la riforma della legislazione in conformità con la convenzione delle nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD): la proposta delle società scientifiche accreditate COMLAS e SIMLA in materia di valutazione di base della disabilità
[2] Ciamarra et al. Leggi delega in materia di disabilità e non autosufficienza e decreti attuativi: nuovi scenari di metodo valutativo per medici legali e spunti di riflessione leggi delega in materia di disabilità e non autosufficienza e decreti attuativi: nuovi scenari di metodo valutativo per medici legali e spunti di riflessione
[3] CERGAS-BOCCONI 2022
[4] per maggiori chiarimenti sul punto si rimanda all’illuminante testo di riferimento di Bruno et al. L’invalidità permanente da malattia nell’’assicurazione privata. Giuffré Ed.